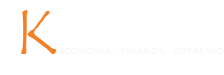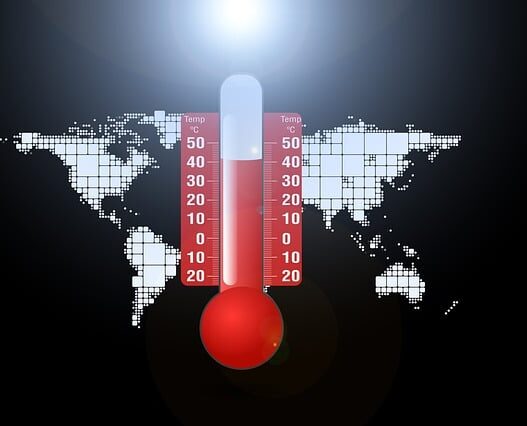Per anni, la lotta al cambiamento climatico è stata presentata come un traguardo condiviso, una missione globale capace di unire governi, imprese e cittadini sotto un’unica bandiera: quella della transizione ecologica. Oggi, però, qualcosa sembra essersi incrinato. Le ultime decisioni prese da alcuni dei paesi considerati pionieri della sostenibilità fanno pensare a una fase di rallentamento — se non di vera e propria retromarcia — nelle politiche ambientali.
L’ultima notizia in ordine di tempo arriva dalla Nuova Zelanda, a lungo celebrata come laboratorio di politiche green. Il nuovo governo di centrodestra, insediatosi alla fine del 2023, ha deciso di allentare in modo significativo le regole sul reporting climatico introdotte nel 2021 dal governo Ardern.
Le società quotate dovranno ora presentare report ambientali solo se hanno una capitalizzazione di almeno 1 miliardo di dollari neozelandesi (contro i 60 milioni precedenti), e i dirigenti non saranno più ritenuti legalmente responsabili in caso di violazioni. Una scelta che, secondo il ministro del Commercio Scott Simpson, serve a “ridurre gli oneri per le imprese”, ma che per molti osservatori rappresenta un passo indietro nella trasparenza e nell’impegno contro le emissioni.
Non è l’unico segnale di svolta: Wellington ha di recente ammorbidito gli obiettivi sulle emissioni di metano, rinunciato alla tassa sugli allevamenti e riaperto all’esplorazione di petrolio e gas offshore. Tutti segnali che indicano un ripensamento profondo della strategia climatica neozelandese, nel nome della competitività e dei costi per le imprese.
Anche in Europa si sente rumore di frenata, o di un ritorno al pragmatismo come dice qualcuno. Negli ultimi mesi, i legislatori dell’Unione Europea hanno concordato di ridimensionare drasticamente le direttive ESG (Environmental, Social and Governance), riducendo l’ambito delle aziende obbligate a fornire report dettagliati sulla sostenibilità. La mossa è stata accolta con favore da parte del mondo imprenditoriale, che lamentava costi eccessivi e troppa burocrazia, ma ha suscitato anche critiche da parte di chi teme che l’Europa stia cedendo terreno proprio sul fronte in cui era più avanti.
E non è finita qui. Bruxelles starebbe valutando di rinviare l’applicazione delle regole contro la deforestazione per i piccoli operatori, lasciando però fuori i grandi player internazionali — una scelta che rischia di indebolire l’impatto complessivo della normativa.
A questo si aggiunge la discussione, riaccesa nelle ultime settimane, sul bando alla produzione di auto a motore termico entro il 2035. Alcuni leader europei chiedono una “pausa di riflessione” e maggiori aiuti all’industria per rendere sostenibile la transizione, segnale di un crescente attrito tra obiettivi ambientali e tutela della competitività industriale.
Dall’altra parte dell’Atlantico, la posizione degli Stati Uniti è piuttosto chiara. Se l’amministrazione Biden aveva rilanciato gli investimenti verdi con l’Inflation Reduction Act, il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca ha stravolto lo scenario.
Già in campagna elettorale, Trump aveva promesso di “smettere di sprecare miliardi in follie green”, definendo la transizione energetica “una minaccia per l’economia americana”. Concetti ribaditi anche nel recente intervento del presidente USA alle Nazioni Unite.
In meno di dieci anni, il tema climatico è passato da urgenza morale a questione di equilibrio economico e politico. Dopo anni di ambiziosi impegni sul cambiamento climatico e regolamentazioni sempre più stringenti, molti governi sembrano oggi spinti a “riallineare” le proprie strategie, citando motivazioni di costo, sostenibilità sociale e realismo economico.
Il rischio, però, è che questa fase di pragmatismo si trasformi in un disimpegno progressivo, con il risultato di rallentare la corsa verso gli obiettivi di neutralità climatica. La sensazione è che la transizione ecologica sia entrata in una nuova fase: probabilmente meno idealista e più concreta. Ma anche pericolosamente più fragile.
Foto di Kanenori