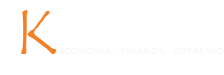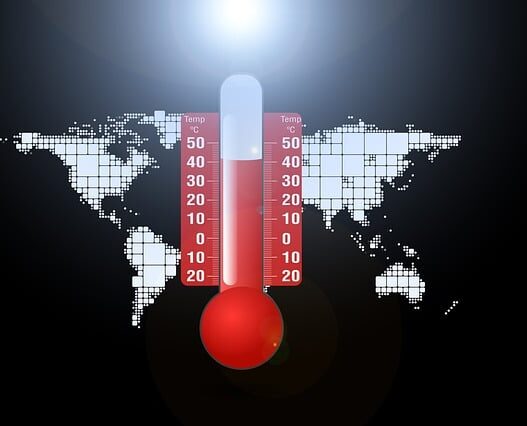Negli ultimi anni dovremmo aver imparato almeno due lezioni. La prima è che in un mondo estremamente interconnesso la qualità delle catene globali di approvvigionamento è fondamentale. La seconda è che il cambiamento climatico non è più un fenomeno lontano e astratto, ma una realtà quotidiana che influisce direttamente sulla nostra economia.
Catene di approvvigionamento e clima sono anche gli ingredienti di uno studio pubblicato da Bruegel (“Climate risks to global supply chains”, 2025), un’analisi che mostra con chiarezza come gli eventi climatici estremi stiano già colpendo le catene globali del valore e come, senza adeguate contromisure, il loro impatto sia destinato a crescere.
Le catene globali di approvvigionamento (le cosiddette global supply chains) collegano fabbriche, campi agricoli, porti e mercati sparsi in tutto il mondo. Sono reti complesse, che funzionano solo se ogni nodo rimane operativo. Ma basta un evento climatico estremo in un punto della catena perché gli effetti si propaghino ovunque.
Un esempio citato dallo studio sono le inondazioni in Thailandia del 2011, che hanno messo in ginocchio la produzione di auto e componenti elettronici. Aziende come Honda e Toyota furono costrette a ridurre la produzione anche in stabilimenti lontani migliaia di chilometri. Eppure, a livello globale, il settore automobilistico riuscì a reggere l’urto grazie alla diversificazione delle forniture. La domanda che gli autori pongono è però inquietante: cosa accadrà quando eventi di questo tipo diventeranno più frequenti e simultanei in più aree del mondo?
Se l’industria può in parte difendersi diversificando fornitori e rotte, l’agricoltura rimane il settore più vulnerabile. Dalla siccità in Brasile che ha fatto impennare i prezzi del caffè, alle ondate di calore in Africa occidentale che hanno colpito il cacao, i mercati agricoli rispondono immediatamente alle variazioni climatiche. Fino ad ora si è trattato di shock temporanei e localizzati, ma con il riscaldamento globale è probabile che diventino più frequenti e più gravi.
Questo non riguarda solo gli agricoltori, ma anche i consumatori: l’instabilità dei raccolti può tradursi in oscillazioni dei prezzi alimentari e, in alcuni casi, in crisi vere e proprie. Lo studio ricorda il caso della “crisi del riso” del 2007-2008, quando le restrizioni all’export adottate da vari paesi esportatori trasformarono un problema gestibile in un’esplosione dei prezzi a livello mondiale.
Il cambiamento climatico non colpisce solo ciò che produciamo, ma anche il modo in cui le merci viaggiano. Canali e fiumi sono essenziali per il commercio mondiale: pensiamo al Canale di Panama, che nel 2023 ha visto ridurre drasticamente il traffico a causa di una grave siccità. Con meno acqua, le navi non potevano transitare a pieno carico, rallentando gli scambi globali e facendo salire i costi di trasporto.
Situazioni simili si sono viste anche sul Reno, arteria commerciale dell’Europa, e sul Mississippi negli Stati Uniti. Se i livelli dei fiumi scendono troppo, le chiatte devono viaggiare più leggere, con un impatto diretto su prezzi e approvvigionamenti energetici e industriali.
Lo studio propone una serie di azioni sia per le imprese che per i governi. Per le aziende, la parola chiave è resilienza: diversificare fornitori, aumentare le scorte strategiche, investire in infrastrutture più resistenti e in tecnologie che riducano il consumo di risorse critiche come l’acqua.
Per i governi, invece, la sfida è duplice: da un lato creare incentivi perché le imprese si proteggano, dall’altro evitare politiche che peggiorano la situazione. Ad esempio, intervenire con sussidi o assicurazioni troppo generose può ridurre gli incentivi ad adattarsi, mantenendo impianti e attività economiche in aree ad alto rischio.
Infine, c’è un aspetto che riguarda tutti: la cooperazione internazionale. Le scelte di un singolo paese – come limitare le esportazioni agricole – possono avere ripercussioni enormi a livello globale. Solo politiche coordinate possono davvero ridurre il rischio di crisi sistemiche.
Il cambiamento climatico non è più un rischio futuro: è un fattore che già oggi influenza produzione, commercio e prezzi. Lo studio di Bruegel ci ricorda che le catene di approvvigionamento globali, proprio perché interconnesse, sono sia fragili che adattabili. La vera domanda è se saremo in grado di rafforzarne la resilienza prima che la frequenza e l’intensità degli eventi climatici estremi superino la nostra capacità di adattamento.
Foto di Markus Kammermann