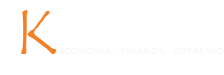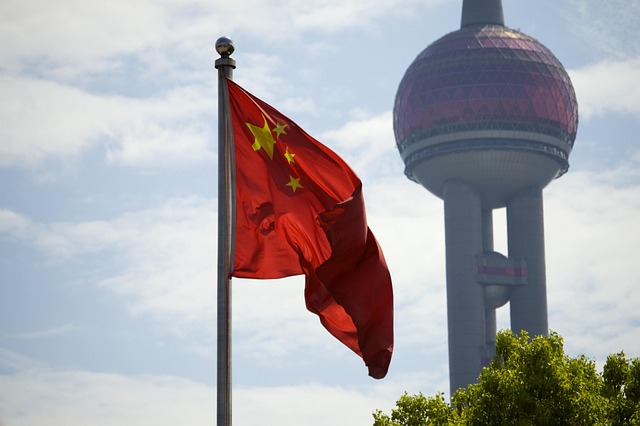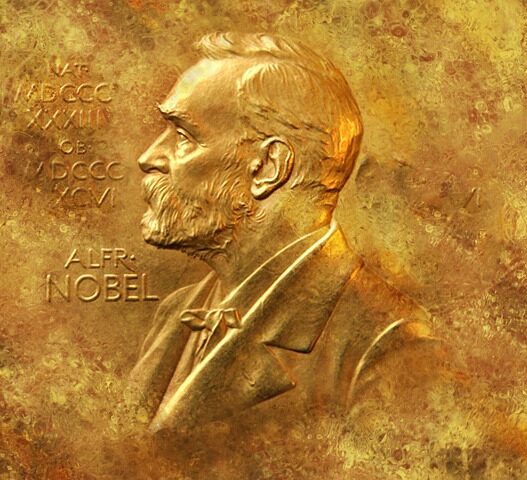Negli ultimi anni il dibattito economico e politico statunitense si è concentrato sul concetto di “reindustrializzazione”. Molti osservatori ritengono che dietro il magico pennello dipinto da politiche aggressive e slogan di “America First” si celi una reazione inevitabile alla deindustrializzazione degli Stati Uniti. Ma cosa ha effettivamente deindustrializzato il paese? Qui entra in gioco il concetto di China shock: una forza disruptive, avviatasi con l’ingresso della Cina nell’Organizzazione Mondiale del Commercio nel 2001, che ha scosso profondamente i mercati globali e, soprattutto, quelli del lavoro nei Paesi avanzati.
Il termine “China shock” si riferisce all’impatto della crescita delle esportazioni cinesi sui mercati manifatturieri degli Stati Uniti e dell’Europa dopo il 2001. Numerosi studi – tra cui quelli di Autor, Dorn e Hanson – hanno rilevato che tale espansione ha causato perdite massicce di posti di lavoro nel manifatturiero, con effetti negativi su salari, partecipazione al lavoro e benessere nei distretti locali più esposti.
Autor, Dorn e Hanson analizzano il periodo 1990–2007 e sfruttano le divergenze territoriali nelle specializzazioni industriali per stimare l’impatto competitivo delle importazioni cinesi. Gli effetti locali sono drammatici: l’aumento della concorrenza dai prodotti cinesi provoca un aumento della disoccupazione, una riduzione della partecipazione alla forza lavoro e del salario medio nelle aree maggiormente colpite. Il loro modello suggerisce che questo fattore spiega un quarto del declino dell’occupazione nel settore manifatturiero statunitense.
In termini quantitativi, la riduzione dell’occupazione manifatturiera spesa può essere attribuita per il 33 % al China shock nel decennio 1990–2000, e per il 55 % nel periodo 2000–2007; nel complesso, circa il 44 % del declino nell’intera fase 1990–2007.
In questo studio successivo, gli autori approfondiscono l’adattamento del mercato del lavoro a grandi cambiamenti nel commercio. Il focus è sulla persistenza degli effetti negativi: gli shock da importazione non solo colpiscono duramente, ma i loro effetti si dimostrano estremamente persistenti nel tempo, con alcune regioni mai completamente ripresesi anche anni dopo.
Gli studi appena citati suggeriscono che le cause profonde della deindustrializzazione americana vadano ben oltre politiche interne poco lungimiranti o “tradimenti” della classe politica verso il settore manifatturiero. Alla base c’è una trasformazione strutturale dell’economia globale, scatenata da uno shock commerciale senza precedenti, caratterizzato da un forte sbilanciamento tra importazioni e esportazioni.
Con l’ingresso della Cina nel WTO e la rapidissima integrazione delle sue fabbriche nelle catene globali di fornitura, gli Stati Uniti hanno visto un aumento massiccio delle importazioni di beni manifatturieri, mentre le esportazioni americane verso la Cina non sono cresciute con la stessa intensità. Questo squilibrio ha significato che i benefici del commercio non si sono distribuiti simmetricamente: l’offerta interna è stata travolta dalla concorrenza cinese in molti settori, ma i mercati di sbocco per le imprese americane non si sono aperti con la stessa ampiezza.
Per fare alcuni numeri: fra il 2001 e il 2018, il deficit statunitense nei confronti della Cina è cresciuto da circa 83 miliardi di dollari a 419,5 miliardi, con un aumento medio di quasi 20 miliardi all’anno. Nello stesso periodo, le importazioni americane dalla Cina sono passate da circa 102,3 miliardi a 483,2 miliardi di dollari, mentre le esportazioni verso la Cina, pur aumentate, sono cresciute meno rapidamente: da 19,2 a 116,1 miliardi (fonte: Economic Policy Institute).
È su questi numeri che politiche come l’introduzione di dazi trovano terreno fertile a livello politico: non perché i dazi siano automaticamente la soluzione ottimale, ma perché rispondono a una percezione reale e diffusa di “gioco truccato”, in cui la competizione internazionale non è a condizioni di parità. I dazi, nella narrazione politica, diventano quindi lo strumento simbolico per “riequilibrare” le regole del commercio, anche se la letteratura economica evidenzia che, da soli, difficilmente riescono a risolvere le cause strutturali di uno shock di questa portata.
Con un percorso diverso ma sintomi simili le ricadute di questo nuovo ordine commerciale mondiale, iniziato nei primi anni del 21° secolo, si sono fatte sentire anche in Europa. Una recente analisi su CEPR spiega che il China shock è arrivato anche in Germania, cuore pulsante della manifattura dell’area, minacciando settori chiave come l’automotive e la meccanica. Ma a differenza degli USA, la Germania ha avuto parte dei danni compensati grazie alla sua integrazione con l’Europa dell’Est.
Studi recenti mostrano che l’integrazione industriale con l’Europa orientale – ricca di risorse umane qualificate e a basso costo – ha permesso a molti settori tedeschi di continuare a crescere, trovando nuova linfa nei mercati limitrofi.
Altre analisi ricordano come in molti paesi europei importazioni cinesi e esportazioni verso la Cina sono aumentate in modo simile, attenuando così gli effetti negativi; in Germania, le esportazioni in settori avanzati come auto e macchinari sono cresciute in parallelo alle importazioni cinesi, conducendo a un bilancio commerciale più equilibrato.
Tuttavia, il nuovo mix competitivo cinese – in cui prodotti ad alto contenuto tecnologico possono ora competere a livello globale – rappresenta una nuova minaccia: secondo un policy brief del CER, la Germania rischia una “sinicizzazione” industriale se non reagisce con politiche coordinate di devoluzione industriale e protezione strategica.
Per provare a fare una sintesi, possiamo dire che il China shock non è solo un’idea astratta alla quale appigliarsi per delineare una linea politica. È stato una forza concreta che ha ridefinito i mercati del lavoro più esposti nel mondo e che continua a lasciare cicatrici persistenti.
Negli USA, il shock ha contribuito a una disoccupazione cronica in alcune regioni, indebolimento dei salari e maggiore dipendenza dai trasferimenti sociali. In Germania, lo shock è stato mitigato da strutture di valore integrate e da mercati regionali, ma la nuova offensiva cinese richiede una reazione politica forte per evitare un declino industriale sistemico. E su questo punto è emblematica l’analisi pubblicata sulle colonne del Wall Street Journal, che evidenzia il calo del surplus commerciale tedesco, la concorrenza diretta delle imprese cinesi nell’elettrificazione e la difficoltà politica interna nell’adottare politiche industriali decise.
Il China shock è la chiave per capire molto di ciò che è accaduto dopo l’inizio del nuovo millennio: non basta attribuire la deindustrializzazione a una debolezza interna o a decisioni politiche sbagliate. Bisogna riconoscere la portata di uno shock competitivo esterno senza precedenti. Ma è anche un invito a imparare:
- Gli Stati Uniti devono rafforzare i meccanismi di adattamento del mercato del lavoro—riqualificazione, mobilità territoriale, sostegni efficaci.
- La Germania e l’Europa devono costruire “resilienza industriale” attraverso politiche coordinate che puntino a preservare le catene del valore e proteggere la base manifatturiera.
Questo esperimento di ricchezza, globalizzazione e concorrenza massiccia non è finito: il China shock continua e le nuove posizioni dominanti del colosso asiatico su alcuni temi strategici (materie prime e know how) sono lì a ricordarci che una seconda ondata di effetti è più che probabile. I dazi non sono la risposta definitiva, probabilmente non lo è nemmeno la reindustrializzazione.
Foto di Gaston Laborde