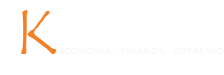Negli ultimi anni, in un mondo segnato da crisi, inflazione e instabilità politica, è tornata al centro del dibattito una domanda fondamentale: quanto devono essere autonome le banche centrali dai governi?
A dare ancora più risalto al tema ci ha pensato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che negli ultimi mesi ha ingaggiato una vera e propria battaglia contro l’attuale governatore della Federal Reserve, Jerome Powell. Le reazioni dei mercati finanziari alla notizia – poi smentita – di una lettera di licenziamento del governatore della Fed pronta per essere recapitata sottolineano come la questione del rapporto tra il potere politico e quello monetario sia estremamente delicato.
L’indipendenza delle banche centrali non è solo una questione tecnica da lasciare agli economisti: riguarda tutti i cittadini, perché tocca la stabilità dei prezzi, la gestione del debito pubblico e – in ultima istanza – il potere d’acquisto delle famiglie.
Due esempi molto diversi, l’Italia prima del 1981 e la Turchia degli ultimi anni, ci aiutano a capire perché l’indipendenza delle banche centrali è più di un principio teorico: è una condizione necessaria per una politica monetaria credibile e stabile.
Ma partiamo dal punto fondamentale. Perchè è importante che le scelte di politica monetaria non dipendano dalla politica? Abbiamo già avuto modo di parlarne e l’idea è semplice: se chi stampa la moneta è troppo vicino al potere politico, allora è più probabile che la moneta venga usata per scopi di breve termine.
In pratica, il governo potrebbe premere sulla banca centrale per tenere i tassi d’interesse artificialmente bassi (per stimolare l’economia o ridurre il costo del debito pubblico), o addirittura chiederle di finanziare direttamente la spesa pubblica. Il risultato? Inflazione. Perdita di fiducia. Fuga dei capitali.
Diversi studi internazionali confermano questa intuizione. Uno studio recente che ha analizzato 155 paesi su un arco di cinquant’anni mostra che le riforme che rafforzano l’autonomia delle banche centrali portano, nel medio termine, a maggiore disciplina fiscale, inflazione più bassa e crescita più sostenibile.
Il Fondo Monetario Internazionale ha definito l’indipendenza delle banche centrali una delle “condizioni istituzionali chiave” per evitare derive populiste e mantenere la stabilità economica, soprattutto nei paesi con debito elevato.
E del resto la tendenza degli ultimi decenni è stata proprio quella di aumentare l’autonomia degli istituti centrali. Un’analisi condotta dal CEPR conferma che dal 1990 a oggi c’è stato un netto trend globale verso l’indipendenza delle banche centrali, riconoscendola come elemento fondamentale per la stabilità economica.
L’esperienza di alcuni paesi sul tema è ancora più esplicativa. E per trovare un esempio decisamente istruttivo non occorre fare troppa strada.
In Italia, infatti, fino al 1981, la Banca d’Italia non era affatto indipendente nel senso moderno del termine. Sebbene formalmente autonoma, nella pratica era fortemente subordinata al Ministero del Tesoro che ne sceglieva il governatore.
Lo strumento più evidente di questa dipendenza era il cosiddetto “obbligo di acquisto dei titoli invenduti”. In pratica, se lo Stato emetteva BTP e il mercato non li comprava, la Banca d’Italia li acquistava automaticamente. In altre parole la banca centrale non faceva altro che stampare moneta per finanziare il deficit.
Il risultato di questo meccanismo fu un’impennata dell’inflazione (che negli anni ’70 arrivò a sfiorare il 20%) e un’accumulazione esplosiva del debito pubblico.
Nel 1981 arrivò la svolta: il ministro del Tesoro Beniamino Andreatta e il governatore Carlo Azeglio Ciampi decisero di separare le carriere e porre fine al meccanismo automatico di acquisto. Da quello che è passato alla storia come il “divorzio” tra Banca d’Italia e Tesoro, la Banca centrale cominciò a comportarsi come un vero istituto autonomo, con il compito di vigilare sulla stabilità della lira e poi preparare il paese all’ingresso nell’euro.
Fu una riforma contestata e ancora oggi discussa, ma ha segnato l’inizio di un percorso virtuoso verso la credibilità monetaria. Un percorso che si è bruscamente interrotto, invece, per la Turchia; il nostro secondo esempio di come gli intrecci tra politica e istituzioni monetarie possano diventare fatali.
Dopo la crisi del 2001, Ankara aveva varato una riforma molto ambiziosa: la banca centrale turca (CBRT) veniva resa formalmente indipendente, con il mandato primario di combattere l’inflazione.
Per un po’ le cose sembrarono funzionare. Ma a partire dal 2018 – con l’accentramento dei poteri nelle mani del presidente Erdoğan – l’autonomia è diventata sempre più nominale.
In pochi anni, si sono susseguiti quattro governatori della banca centrale, spesso rimossi perché troppo “ortodossi” nella gestione della politica monetaria.
Erdoğan ha sostenuto pubblicamente una teoria eterodossa secondo cui tassi alti causano inflazione, e ha spinto la banca centrale a tagliare i tassi anche quando l’inflazione era già fuori controllo.
Il risultato è stato drammatico: tra il 2021 e il 2022 l’inflazione è volata oltre l’80%, mentre la lira turca ha perso più del 60% del suo valore contro il dollaro.
Il governo ha cercato di tamponare vendendo riserve in valuta estera, ma senza una strategia credibile e indipendente, i mercati hanno perso fiducia.
Solo nel 2024-25, con l’arrivo di una nuova leadership tecnica alla banca centrale, la Turchia ha iniziato un lento ritorno a politiche ortodosse: rialzi dei tassi, maggiore trasparenza, segnali di distacco dal potere esecutivo. Ma i danni fatti alla credibilità monetaria richiederanno anni per essere riparati.
Due esempi – ma se ne potrebbero citare molti altri – che fanno riflettere e dovrebbero essere ben presenti in ogni discussione che riguarda il ruolo della politica sui meccanismi monetari. L’esperienza di questi due paesi, così diversi per storia, economia e politica, porta alla stessa conclusione: una banca centrale indipendente è una condizione necessaria – anche se non sufficiente – per garantire stabilità macroeconomica. In Italia, il “divorzio” del 1981 ha permesso alla banca centrale di focalizzarsi sulla stabilità dei prezzi, senza più essere subordinata alle esigenze del Tesoro. In Turchia, al contrario, l’interferenza politica ha trasformato un’inflazione gestibile in una crisi di fiducia con pesanti ripercussioni economiche.
Autonomia, però, non significa isolamento: una banca centrale deve saper comunicare, coordinarsi con il governo quando necessario, e rendere conto delle proprie scelte. Ma la linea tra collaborazione e subordinazione non deve mai essere superata.
In un’epoca in cui la tentazione di usare la politica monetaria per risolvere problemi politici è forte – dal finanziamento del debito alle pressioni per stimolare la crescita – l’indipendenza delle banche centrali resta un presidio fondamentale di responsabilità economica.
Non è un lusso da tecnocrati: è una garanzia per tutti. E ogni volta che viene messa in discussione, come nella sostanza sta accadendo, dobbiamo ricordarcene.