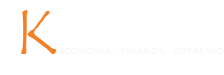Quando pensiamo al commercio internazionale, l’immagine classica che viene in mente è quella della teoria del vantaggio comparato di David Ricardo: ogni Paese si specializza nei beni che produce in modo relativamente più efficiente, e li scambia con altri Paesi per ottenere ciò che produce meno bene. Questa visione, semplice e potente, ha dominato la teoria economica per quasi due secoli.
Eppure, osservando i flussi commerciali moderni, qualcosa non tornava. Perché Paesi con strutture produttive simili, come Germania e Francia, si scambiano automobili? Perché l’Italia esporta moda e importa moda, o gli Stati Uniti esportano software ma ne importano altrettanto? È qui che entra in scena Paul Krugman, premio Nobel per l’economia nel 2008, con la sua “nuova teoria del commercio internazionale”.
Krugman parte da un’osservazione: il commercio non avviene solo per differenze di risorse o di tecnologia. Esiste anche un commercio “intra-industriale”, dove Paesi simili scambiano beni simili. Secondo la teoria classica, questo fenomeno non avrebbe molto senso; secondo Krugman, invece, è il risultato naturale di due fattori chiave: economie di scala e preferenze per la varietà.
Le economie di scala si verificano quando il costo medio di produzione diminuisce all’aumentare della quantità prodotta. In pratica, se una fabbrica di automobili produce per un mercato globale, può abbassare i costi rispetto a una che produce solo per un mercato nazionale. Questo spinge le imprese a specializzarsi e a vendere all’estero.
Le preferenze per la varietà derivano dal fatto che i consumatori non vogliono solo “un’auto”, ma desiderano una scelta tra modelli, marchi e stili differenti. Lo stesso vale per vestiti, computer, elettrodomestici e molti altri beni. Il commercio internazionale permette a un Paese di avere accesso a una gamma di prodotti più ampia di quella che potrebbe produrre da solo.
Immaginiamo due Paesi identici in termini di tecnologia e risorse, ma con produttori specializzati in diversi modelli di auto. Se ciascun Paese si limita al proprio mercato interno, le varietà disponibili saranno poche e i costi più alti. Se invece aprono le frontiere commerciali, ogni Paese potrà esportare il proprio modello distintivo e importare quelli dell’altro. I consumatori avranno più scelta, le imprese venderanno di più, e grazie alle economie di scala i costi scenderanno.
Questo spiega perché l’Unione Europea o l’Accordo USA-Canada-Messico non portano a una “competizione diretta” che elimina produttori, ma piuttosto a un arricchimento dell’offerta e a una maggiore efficienza.
Il quadro cambia radicalmente quando si introducono barriere commerciali come i dazi. Nel modello di Krugman, i dazi riducono il volume degli scambi proprio nei settori dove si guadagna di più in termini di varietà e sfruttamento delle economie di scala.
Un dazio fa aumentare artificialmente il prezzo dei beni importati. Questo ha tre effetti principali:
- Meno varietà disponibile: i consumatori hanno accesso a un numero inferiore di modelli o marchi, perché le importazioni diminuiscono.
- Economie di scala più deboli: le imprese nazionali, vendendo solo sul mercato interno, producono meno e non riescono a diluire i costi fissi su grandi volumi. I costi medi aumentano.
- Prezzi più alti per tutti: con meno concorrenza estera e produzioni più piccole, i prezzi interni tendono a salire.
Questo significa che i dazi non colpiscono solo i produttori stranieri, ma anche i consumatori e le stesse imprese nazionali, che perdono l’opportunità di crescere grazie a mercati più ampi. È per questo che, all’interno della logica di Krugman, il protezionismo ha un costo doppio: riduce il benessere immediato dei consumatori e indebolisce le basi della competitività nel lungo periodo.
Un esempio concreto si può trovare nel settore automobilistico tra Stati Uniti ed Europa. Quando gli USA impongono dazi sulle auto europee, non colpiscono solo marchi come BMW o Mercedes, ma anche i consumatori americani, che vedono diminuire la scelta e aumentare i prezzi, e persino produttori locali che si riforniscono di componenti europee.
In un’epoca di ritorno delle politiche protezionistiche, la teoria di Krugman è un promemoria importante: i benefici del commercio moderno derivano dalla possibilità di specializzarsi e ampliare la varietà dei beni disponibili, non solo dallo scambio di prodotti “diversi” tra Paesi “diversi”. Limitare questo meccanismo con dazi o barriere può tradursi in meno efficienza, meno innovazione e prezzi più alti, proprio il contrario di ciò che un’economia aperta e competitiva dovrebbe perseguire.
Foto di Freddy