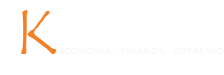Qualche giorno fa abbiamo parlato dell’ultimo libro di J.K. Galbraith e di come i modelli economici basati sul concetto di equilibrio di lungo periodo possano portare a valutazioni errate. Oggi riprendiamo l’argomento dei modelli economici, soffermandoci su un aspetto particolare, vale a dire la frequenza di aggiornamento. Una ricerca di Isaac Baley e Javier Turen ci introduce ai concetti di previsioni economiche a scatti e inazione razionale, vediamo di cosa si tratta.
Nel dibattito economico e nei media, è ormai prassi dare per scontato che gli esperti aggiornino costantemente le loro previsioni man mano che emergono nuovi dati. L’idea è che ogni variazione nel contesto macroeconomico – un cambiamento nei tassi d’interesse, un nuovo dato sull’inflazione, un segnale dal mercato del lavoro – debba tradursi immediatamente in un aggiustamento delle stime da parte di analisti, economisti e centri di ricerca. Ma cosa succede se questo aggiornamento non avviene? E se, anzi, i professionisti sembrano rimanere fermi per lunghi periodi, per poi rivedere le loro previsioni in modo improvviso e consistente?
A questa domanda risponde un interessante studio a cura di Isaac Baley e
Javier Turen, pubblicato su VoxEU, che analizza il fenomeno delle cosiddette “lumpy forecasts” – ovvero previsioni economiche aggiornate in modo irregolare, “a scatti”. Lo studio parte da un’osservazione empirica: i professionisti non aggiornano le loro previsioni ogni volta che arriva una nuova informazione. Al contrario, tendono a mantenere invariati i loro outlook anche per mesi, per poi correggerli in modo significativo in determinati momenti.
Questa apparente “inerzia” potrebbe sembrare una forma di inefficienza o addirittura di pigrizia intellettuale. In realtà, gli autori dello studio propongono una lettura più sottile: si tratta di inazione razionale. In altre parole, i previsori professionisti si comportano così non perché trascurano il cambiamento, ma perché scelgono deliberatamente di non reagire a ogni variazione marginale.
Tra le ragioni che spiegano questa scelta ci sono i costi cognitivi e organizzativi legati all’aggiornamento delle previsioni. Ogni revisione comporta un dispendio di tempo, risorse e attenzione, oltre a implicazioni comunicative, soprattutto in contesti aziendali o istituzionali. Inoltre, molti dati economici sono affetti da rumore statistico: reagire a ogni piccola oscillazione rischia di produrre revisioni inutili o fuorvianti.
C’è poi una componente legata alla reputazione: cambiare troppo spesso idea potrebbe far apparire il previsore come poco solido o incoerente, soprattutto in ambienti dove l’affidabilità percepita conta quanto, se non più, della precisione tecnica.
Baley e Turen mettono in evidenza che, dal punto di vista della teoria economica, questo comportamento può essere modellato come una risposta ottimale a un problema di “costo di inazione”, analogo a quello che spiega perché anche i prezzi non si muovono continuamente nei mercati con frizioni. Le implicazioni di questa dinamica sono tutt’altro che banali: se chi formula previsioni – e queste previsioni vengono poi utilizzate per prendere decisioni politiche, aziendali o finanziarie – reagisce con ritardo ai cambiamenti dell’economia reale, allora anche le politiche pubbliche e le scelte strategiche potrebbero muoversi con inerzia, perdendo efficacia.
Foto di Marco Beschizza