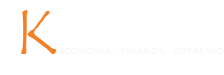Ha destato particolare interesse e non poche preoccupazioni la storia di Jacob Irwin, raccontata qualche giorno fa dal Wall Street Journal. Riassumendola per sommi capi, Jacob ha sviluppato deliri maniaco-depressivi dopo che per mesi ChatGPT ha continuato a confermare e supportare la sua teoria sulla possibilità di effettuare viaggi più veloci della luce; e questo nonostante lui stesso esprimesse dubbi sulla propria sanità mentale. Il WSJ racconta quello che sembra un vero e proprio calvario: tre ricoveri ospedalieri, la perdita del posto di lavoro e un comportamento sempre più aggressivo nei confronti dei familiari.
Un caso al limite, si potrebbe sostenere, ma la letteratura già da qualche tempo ha iniziato ad indagare quella che viene chiamata ChatGPT psychosis e che è collegata ad una evidente difficoltà da parte dei modelli LLM di distinguere la differenza tra illusione e realtà e di avere un atteggiamento estremante compiacente nei confronti dell’utente che li utilizza. Una debolezza, questa, che unita ad uno spirito critico debole da parte dell’utilizzatore può portare a risultati fatali, come racconta uno studio dell’università di Stanford.
Da un punto di vista economico, racconti e studi come quelli appena citati non fanno altro che alimentare le domande sugli effetti che un utilizzo sempre più massiccio e pervasivo dell’intelligenza artificiale possa avere sui lavoratori e sul loro benessere fisico e mentale. A questo proposito, indicazioni interessanti ci arrivano da un recente studio condotto da Osea Giuntella, Luca Stella e Johannes König. La ricerca – pubblicata recentemente dal CEPR – analizza l’esperienza tedesca nel periodo 2000-2020, utilizzando i dati del German Socio-Economic Panel. In particolare lo studio ha analizzato l’impatto dell’IA da due prospettive diverse: task-based, cioè in base ai compiti associati alla professione iniziale del lavoratore; e self-reported exposure, vale a dire l’utilizzo dell’IA dichiarato dal lavoratore.
Se dall’analisi task-based, nel complesso, non emerge alcun impatto significativo dell’esposizione all’IA su ansia, depressione o benessere mentale generale, i numeri cambiano utilizzando la prospettiva self-reported exposure. In quest’ultimo caso, infatti, a partire dal 2015, i lavoratori in occupazioni esposte all’IA hanno iniziato a riferire di una leggera diminuzione della soddisfazione di vita e della soddisfazione lavorativa.
In sintesi, la ricerca mostra che l’introduzione dell’intelligenza artificiale sul lavoro, valutata con criteri oggettivi, mediamente non peggiora il benessere mentale o la soddisfazione dei lavoratori — e può portare addirittura ad un miglioramento della salute fisica. Ma emergono segnali di insoddisfazione soggettiva quando l’uso dell’IA è percepito come eccessivo o destabilizzante.
Pur con tutti i limiti che una ricerca di questo genere porta con sé, quello che sembra emergere ancora una volta, e in tutta la sua importanza, è la necessità di governare questo passaggio epocale; di formare i lavoratori ad interpretare l’intelligenza artificiale come strumento di lavoro e non come entità sostitutiva o, peggio, superiore.
Foto di cocoandwifi